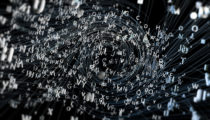Il Novecento, questo sconosciuto. Pubblichiamo l’articolo del prof. Giuseppe Langella,…

Ricordo di Amedeo Quondam
Ho conosciuto Amedeo Quondam nella metà degli anni Novanta, quando ero ancora dottorando. Ben presto Quondam mi introdusse alle sue avventure di organizzatore vulcanico di seminari, convegni, simposi internazionali. Ebbi in quelle occasioni l’opportunità di imparare molto, sia sul piano dei contenuti disciplinari, sia su quello di progettazione infaticabile.
Il termine che riassume il pensiero critico di Quondam era il classicismo. Attraverso i secoli, in una campata veramente ampia (da Petrarca a Leopardi), l’idea era quella che il classicismo avesse prodotto, nella sua sostanza effettuale e nella sua forma mentis, una civiltà radicata in principi quali la mesotes, la proportio, il prepon e quant’altro. La forma del vivere era per lui regolata dall’etica e la topica del gentiluomo, non soltanto in Italia ma anche all’estero (dedicò studi al gentleman). Le competenze del gentiluomo erano in primis la conversazione, la parola, ma anche quella scritta. L’imitazione di Petrarca era espressa, al culmine del Rinascimento (o Rinascita), da libri chiave come Il Cortegiano del Castiglione, La civil conversazione di Guazzo, il Galateo di Giovanni della Casa. Al libro di Castiglione in particolare, Quondam ha dedicato volumi imponenti, di interpretazione e di constitutio textus. E non si può non ricordare l’edizione del libro del Guazzo, con un’annotazione vasta ed esemplare. Anche se in un testo come il Galateo l’influsso petrarchesco sembra remoto, certo l’autentica “moda” del petrarchismo ebbe nel Cinquecento il suo culmine: si pensi ai “petrarchini” raffigurati fra le mani di illustri dame.
Classicismo, si diceva. E longue durée, una perennità – quasi – che partiva da Petrarca, dalla sua concezione imitativa dei classici e dei moderni, fino alla rivoluzione francese ed oltre, con il suo amato Foscolo e con Leopardi. La sua nozione sociale e secolare del classicismo non era però una notte in cui tutte le vacche sono grigie, bensì una civiltà intera, plurisecolare, che non ignorava le diverse modalità espressive, ma che tutta egli includeva in un circolo amplissimo che manteneva intatti i parametri dell’imitatio, dell’aristotelico in medio virtus (anche negli autori che altri definirono anticlassicisti), dell’etica comportamentale, di una micro-etica, cioè, che investe il decorum letterario-sociale. Quando gli parlavo di discontinuità, di faglie profonde (ad esempio il passaggio dall’età di Tasso ai primi decenni del Seicento, che mi sembra tuttora il luogo e il momento in cui si scopre un nuovo senso della realtà, nella scienza come nella poesia), il maestro storceva il naso. La sua concezione di una invincibilità del modello perenne era granitica e affascinante, profonda e intelligente proprio perché discutibile, nel senso positivo del termine. Ed ebbe spesso l’idea che la tradizione critica seguace della categoria di “decadenza” si fosse occupata solo di “non letterati”, quali Bruno e Galilei, ignorando il grande contributo mariniano e marinistico.
La società di Ancien régime è vissuta per secoli, secondo il pensiero quondamiano, regolando norme sociali e forme artistiche; non conobbe determinanti intoppi o scambi bruschi di prospettiva. Se il Cinquecento era il punto centrale di questa idea storiografica, il secolo che precedette la Rivoluzione francese non fu tanto una forma di “restaurazione” ma di continuità, nell’Arcadia e in autori come il Gravina, su cui Amedeo scrisse la sua prima grande monografia.
Tutto ciò non poteva non giungere a un incontro-scontro con la figura più significativa del secondo Ottocento: Francesco De Sanctis. A questi dedicò una delle sue ultime monografie, densa e poderosa come le precedenti. La prospettiva desanctisiana di una corruzione e decadenza sino alla progressiva costituzione di un “realismo”, attraverso autori quali Goldoni, Parini, Alfieri, Foscolo, Leopardi e finalmente una nuova coscienza critica e politica postunitaria, venne totalmente messa in discussione da Quondam. Il mito della “decadenza” fu la sua bestia nera. Secoli come il Seicento o il Settecento arcadico-metastasiano non furono momenti di decadenza sociale e letteraria, tutt’altro. La liquidazione della poesia del sec. XVIII in musica, un motivo ben presente in quel romanzo che è la Storia della letteratura italiana, era parte di una mitologia teleologica che Quondam discusse e devastò con sempre intensa energia. De Sanctis, che definisce la narrativa cinquecentesca la putrefazione del Boccaccio, rifiuta ogni forma che sia imitazione e costituisca un modello esterno al realismo, che si costruisce a poco a poco per trionfare progressivamente nel Settecento. La mia tendenza a rilevare discontinuità si scontrava con un pensiero così compatto e dimostrabile che quasi era inscalfibile. Questa la grandezza di chi non è soltanto immerso in puntuali studi letterari microscopici, ma guarda con coraggio e orgoglio alla tradizione secolare, e con lui sono stati i veri maestri della nostra generazione: maestri che volgarmente vengono chiamati “generalisti” massime adesso, nell’età neopositivista che stiamo vivendo.
L’interesse di includere più figure possibili nell’orizzonte vasto della tradizione come la leggeva lui lo ha portato di recente a gettarsi corpo a corpo sul Decameron, e, prima, a ritornare su Petrarca definendolo un italiano dimenticato a tutto favore di Dante. Petrarca sembra scendere in seconda fila nell’età contemporanea, anche se, aggiungeremo, molta poesia da Mallarmé in poi ha Petrarca nel sangue, ricostruendo emblemi puri, oggetti araldici propri dell’antirealismo del Canzoniere.
Credeva Quondam in una possibilità di realismo? Il termine gli sembrava scomodo, tutto è realismo e tutto è classicismo, in un universo che perviene alle contraddizioni (sublimi) di Leopardi antiromantico e assegnato sul piano europeo proprio al romanticismo. Anche Leopardi è figlio del’imitatio, e proprio dell’imitazione di Petrarca (da cui eredita parole e astrazioni) nonché di Metastasio, per il quale gli autori sommi cui guardare erano Marino (!), Guarini e Tasso. Il classicismo di Saba e pure di Ungaretti confermano una linea davvero permanente, ma le estremità novecentesche non erano precisamente l’oggetto del nostro.
Quondam ci lascia un’eredità che solo i veri maestri possono offrire: discuterla e amarla sarà per noi un continuo, rinnovato piacere intellettuale. La sua scomparsa ha generato vera costernazione in chi lo amava e in coloro che erano e sono entusiasti della sua riflessione critica così grandiosa.
Vivat Quondam 1943-2024
Roberto Gigliucci